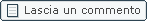.2email-ME
.arteadesso.net
.sito su arteadesso
.wet paint / wet pixels
cgmetapol
diapason
EDGE
erodiade
fragmentart
harz [S.Zangrando]
heteronymos
huge-entity
il primo amore
karpos
kelebek [M.Martinez]
la poesia e lo spirito [blog collettivo]
Long Sunday
Lulu
nazione indiana 2.0
nevedicarne II
par3rg0n
perchéno???[E.Merlina]
Renato Calligaro
res cogitans
tashtego
tempofermo
tracciamenti
universopoesia
v.1 of this.
VDH's private papers
wacquant
zaccheo jr
|.ilpuntoagosto2006
|01 carte segnate
|02 tirteo
|03 rinvio permanente
|04 stupidi appetiti
|05 sennett
|06 il come e il cosa
|07 real bacon
|08 surrealismo folk
|09 spiegazione di bateson
|10 basi razionali
|11 cruel enough?
|12 dialoghetto
|13 l'happy hour
|14 a gun can save your life
|15 ship of fools
|16 you are free
|17 deja-vu
|18 right or wrong
|20 devo imbrogliare!
|21 what motivated me
|22 ManinPesto
|23 stop&go
||01 soliloqui
||02 severino
||03 processo invertito
||04 fucking culture
||05 christo
||06 paco
||07 maniacco
||08 hierarchies
||09 riassumere
||10 retoriche
||11 ressentiment
||12 IULM
||13 uff
Il filosofo Daniel Dennett chiama “basi razionali liberamente fluttuanti” quelle ragioni, principi strategici, che non sono rappresentati, codificati esplicitamente da nessuna parte, ma sono impliciti “nell’organizzazione più vasta degli aspetti programmati”: “è sconvolgente osservare”, dice portando l’esempio del cuculo, “la feroce perseveranza e la quantità di risorse con cui il giovane uccello supera qualunque ostacolo si frapponga fra lui e l’obiettivo di disfarsi delle altre uova. Perché lo fa? [..] Naturalmente agisce in modo inconsapevole; non ha la minima idea della base razionale del suo atto spietato, ciò nondimeno la base razionale è lì, ed è indubbiamente lei ad aver plasmato, nel corso di eoni, questo comportamento innato”. Il tema della scalata alle gerarchie, dell’accesso alle posizioni dalle quali si raggiungono “milioni di persone”, smuove sempre, in questi ambienti, una libido enorme. Mozzi ha dato una nuova rimestata alla vecchia questione, questa volta in senso apparentemente inverso rispetto alla volta della “restaurazione”, quando appariva quasi come il capo dei moderati, dei semi-integrati. Anche in questo frangente, sono state esposte molte ragioni - basi razionali - pertinenti ed importanti. Però, esattamente come quella volta, mi rimane l’impressione di una mancanza, di una stonatura, come se non si tenesse abbastanza presente la differenza fondamentale tra il rapporto “uno-molti”, che struttura quei mezzi (cioè l’industria culturale) ed il rapporto “uno a uno” che caratterizza Internet. Mi immagino di chiedere, ai miei apprezzati autori, ma come? Avete qui decine di interlocutori e con la coda dell’occhio guardate (sbavate) sempre verso di là, verso le centinaia di migliaia - numero inconcepibile - di “semplici lettori”? D’accordo, sono ottime ragioni, ma non dovrebbero venire DOPO, magari ALTROVE queste basse (sulla piramide di Maslow :) questioni? Lo rinfacciavo anche (aihmè, senza il tatto e l’abilità necessari) a Scarpa e Benedetti: ma come? Ci svelate così bene le “macchine di ottundimento delle menti” e poi ce le replicate qui nel piccolo, facendo leva sui carismi, tirando fuori la lagna dell’ “io sono uno e voi siete tanti”, rispondendo solo ai “riconosciuti”, rinnegando la pariteticità di Internet? Non riuscivo proprio a conciliare la loro esibizione di una critica lucida, spietata, radicale - ma purtroppo sempre orientata, come un laser, verso precise direzioni del campo - con la contemporanea riproposizione (forse inconscia, forse dettata “dall’organizzazione più vasta degli aspetti programmati”, cioè semplicemente dall’adesione al campo letterario) di pose e mitologie assurde, da trickster - da “bricconi” che non possiamo più riconoscere come “divini”, anche perché, adesso che in certo modo “viviamo” con loro, vediamo direttamente il respiro dei loro pensieri, e li sappiamo totalmente umani. Li accusavo di saper oggettivare tutto all’infuori di loro stessi, ma se ne sono andati prima di potermi rispondere, lasciandomi nel mio “double bind”. Adesso leggo le parole di Gemma: la frase “sono scritti da dio” mi ha colpito moltissimo. Mostra un’adesione al gioco, una fede nella Scrittura e nei suoi poteri, che mi fa quasi vergognare dell’aridità connaturata al mio scetticismo. Allora comprendo di essere ancora molto lontano dall’avere una rappresentazione adeguata di tutte queste cose, intuisco l’esistenza di “ragioni liberamente fluttuanti” che mi sono ancora completamente invisibili. @MarioB L’abilità tecnica non è tutto – ci sono gli invisibili “paesaggi di potenziale” determinati tanto dall’attività del campo artistico (cioè dalla sua storia) quanto dalle dinamiche psichiche generali alle quali essa in qualche modo si appoggia (si separino i due aspetti, se ci si riesce!) - ma senza tecnica non c’è arte. Ma bisogna intendersi sui termini: per tecnica io preferirei intendere il lato conscio, esplicitato o esplicitabile (in termini di ricette, lezioni, raccomandazioni) di quello stesso “sapere” che dall’altro lato si inabissa, attraverso l’esercizio e la formazione delle abitudini, nel corpo, divenendo così prevalentemente inconscio. Lo stile risulta da questa mescolanza di saperi, più o meno integrata, più o meno profonda, più o meno efficace, nei suoi risultati, sul prossimo. Nel detto banale “de gustibus…” c’è la verità ineliminabile dell’irriducibilità dei percorsi di differenziazione. Chi ha ragione sull’opera in oggetto? Gemma o Mario? Non dovremmo accettare la “differenza” senza mettere per forza in ordine i due termini? Non è ora di fare giustizia dell’intolleranza estetica? Io suppongo che gli strumenti ormai ci sarebbero, solo che troppi lo sentirebbero come una “scomposizione empia”. . Certo, e la competizione c’è sempre, anche quando le poste in gioco si fanno più eteree. Il mio non era un appello ad un “volemose bene” indifferenziante, ma a cercare di distinguere fra ragioni in linea di principio “condivisibili” su base razionale, e quelle che fanno appello a rispondenze più profonde, affinità elettive, ecc. (comunque ce ne vogliamo spiegare l’origine). Confondere i due piani è fare propaganda, ottundere le menti. Poi anche la propaganda può avere nobili fini, diciamo così “pedagogici”, ma se viene dichiarata come tale uno può magari scegliere se assogettarvisi. Solo che quella separazione è l’atto costitutivo implicito del nostro ritrovarci qui, così come i protomoderni dell’ “arte per l’arte” si separavano dalle logiche del mercato borghese, o da quelle sociali della bohéme, puntando ad un mercato più etereo e, mi si passi la contraddizione, “più eterno”. Tutti noi mettiamo da parte le giustificatissime lagne per la lobotomia soft che il lavoro (la vita) ci impone, e ci arrabattiamo come possiamo. I tentativi di reintrodurre differenze ontologiche, basate sulla mistica dell’Autore, dalle quali conseguirebbe che Raimo qui non sta facendo, come tutti noi, del semplice “esercizio”, attraverso “prodotti” che sa benissimo non essere convertibili in moneta sonante (altrimenti l’avrebbe già fatto) ma si starebbe invece “sacrificando” per noi … beh, gli direi solo questo: questo spargimento di sangue a me non serve. >Io credo che il pubblico .. vada “educato” .. ho bisogno di .. vederle battersi per imporlo .. per abituare chi crede che .. a guardare un po’ più in là del loro ristretto e asfittico orizzonte. Toh’, è uscito il diavolo! In tal caso preferisco il mercato. Ti ricordi, nelle allucinazioni del Sant’Antonio di Flaubert, gli eremiti che scendono giù in città a massacrare la gente con i loro bastoni? Questo mi ricordano spesso i poeti che trovo sulla rete. So naturalmente di proiettare, ma tant’è. Avvertendo Ugolino che non ce l’ho con lui (al contrario, ha tutta la mia stima etc etc – sono sincero ma non amo i salamelecchi) ma semplicemente “proietto” sulle sue parole in base alla mia “agenda” (se Leonardo vedeva battaglie nella muffa dei muri, se i surrealisti trovano ancora ispirazione nella scrittura automatica, pensiamo a quanto più ricco e fertile sia già questo spazio - se abbandoniamo esplicitamente la pretesa di poter risalire ad alcuna “verità” sulle persone che sappiamo essere all’origine del meraviglioso sbocciare di questi frammenti testuali). Dunque aggiungo qualcosa alla faccenda del diavolo: forse non si tratta di una chiave alternativa ma dell’altro lato – o addirittura dello scheletro – della sua stessa chiave, che naturalmente sono in grado di intendere nel suo significato primo. Mi stupiva (ma non mi indignava affatto) che in un discorso così ben intenzionato potesse inserirsi un così chiaro esempio di meccanismo persecutorio. La poesia è certamente una gran cosa, Cepollaro un grande poeta, ma perché questa “grazia”, questo gusto superiore e fortunato, ha bisogno di una “vittima” sulla quale costituirsi? Perché questi cenacoli hanno sempre bisogno di chiudere il loro dannato cerchio sacro, fondare la loro differenza maledicendo, e al tempo stesso chiamando a gran voce, chi ne sta fuori? Se guardiamo attentamente poi, quella vittima neppure esiste: nessuno pensa che gli “oregli” siano la poesia (che bella pretesa questa, di leggere nell’anima di una moltitudine) e chi è escluso oggettivamente dalla poesia lo è di solito per motivi abbastanza comprensibili, simili a quelli che escludono (forse) te e me dalla fisica quantistica, tanto per fare un esempio. Ma mettiamo pure che ci sia una carenza organica, che essi manchino di un “organo della comprensione”, come vuole, con costernante serietà, Ortega Y Gassett. Che vantaggio potrebbero allora trarre dall’essere chiamati a gran voce a constatare la propria inferiorità? Oh certo, gli si offre anche una qualche sorta di elevazione, un percorso iniziatico - se solo avranno l’umiltà di mettersi in ginocchio come catecumeni - ma la chiave della differenza deve rimanere ben custodita: da qui la lagna insopportabile dei “troppi che scrivono e pochi che leggono”. Io invece mi rallegro che tanti preferiscano scrivere le proprie cazzate piuttosto che leggere le cazzate altrui. Lo trovo un aspetto sano, un portato ineliminabile dell’istruzione di massa. E penso che l’equilibrio si formerà da solo, non si modellerà certo sui desideri degli opportunismi di parte (non sto parlando di te, a scanso di equivoci) per quanto inconsci questi possano essere. Grazie Ugolino, ricambio l’apprezzamento. Riguardo ai “Barbari”, rispetto le considerazioni di Prodan, però aldilà di quanto possa essere considerata “vera” (la distanza che si apre tra una narrazione a quel “livello di granularità” e l’infinitamente differenziabile realtà mi dà le vertigini) una simile chiave esplicativa, devo dire che apprezzo molto il modo, né dogmatico né reticente, con cui viene posta. Insomma “in me” l’esplicazione funziona, mi fornisce quel particolare senso di sollievo alle tensioni interpretative che forse rappresenta l’unico “adattamento“ che può fornire questo genere di “teoria”. A questo livello, apprezzo la forma sistemica (ci sento Bateson!) che respira nella tesi generale, e posso perdonare che gli esempi forniti possano risultare stiracchiati ad un occhio più esperto. Alcuni punti però, mi sembrano addirittura “veri”, perché li sento tali nel vissuto, sentendomi io stesso un mezzo barbaro (più per costrizione che per scelta). Eccone uno: “Ma oggi? Avete in mente le ore di studio e di ascolto necessarie per creare quello che Adorno chiamava un “ascoltatore avveduto”, cioè l’unico in grado di apprezzare veramente il capolavoro? E avete in mente con quanta costanza si sia demonizzato qualsiasi altro modo di accostarsi al sommo capolavoro, magari cercandovi con semplicità il crepitio di una vita immediatamente percepibi le, e dimenticando il resto? Come insegna la musica classica, senza fatica non c’è premio, e senza profondità non c’è anima. Andrebbe anche bene così, ma il fatto è che la sproporzione ormai fra il livello di profondità da attingere e la quantità di senso raggiungibile è diventata clamorosamente assurda. Se vogliamo, la mutazione barbara scocca nell’istante di lucidità in cui qualcuno si è accorto di questo: se effettivamente scelgo di dedicare tutto il tempo necessario a scendere fino al cuore della Nona, è difficile che mi resti del tempo per qualsiasi altra cosa: e, per quanto la Nona sia un giacimento immenso di senso, da sola non ne produce la quantità sufficiente alla sopravvivenza dell’individuo. “ Caro GiusCo, potresti spiegarmi bene (e gratuitamente) quel “si fa icona” della parola poetica? Può essere un “insight” molto intrigante. Sii pure didattico e verticale, a Judo si diceva “onegaiscimass!”. GiusCo non risponde. Fa niente, mi rispondo da solo e tiro avanti. Qui non c’è una questione di democrazia o di pietismi. Conviene trattare bene tutti, così c’è meno casino inutile, ma nessun “più sfaccettato” è obbligato a zavorrarsi interagendo con i “meno sfaccettati”. Il problema è che nell’estetica ci si sfaccetta in maniere irriducibilmente differenti, ovvero per via “carismatica”, per innamoramenti, per plagi precoci ecc. con tutto il settarismo cieco che questo comporta. Da questo l’incredibile, ma in fondo innocente, ferocia dei poeti appartenenti a “giri” diversi, quando poi si tratta davvero di dover buttare giù qualcuno (in realtà quasi tutti) dalla torre. Nell’arte “high money” inaugurata da Warhol, questo è perfettamente evidente: contano gli “amori” del personaggio carismatico: grafici divertenti come Haring o graffittari come Basquiat ce n’erano a iosa in america, esattamente come ci sono poeti a iosa in Italia (oppure qualcuno pensa davvero di riuscire a mostrare, esplicitare, una qualità intrinseca che prescinda dai carismi che il denaro o la celebrità sono ormai in grado di proiettare su un corpo d’opera qualunque? beh, non proprio qualunque, ma basta un minimo di scaltrezza per evitare gli “stilemi” già condannati). E dunque il confronto andrebbe istituito con scienza e tecnologia, per nulla democratiche o pietiste, e con i loro meccanismi di esclusione od inclusione. Servirà un salto cognitivo, altrimenti, vedere i poeti aggregarsi in rete sarà come vedere uno che tenta di mischiare un mazzo di carte fatte con la carta di vetro: mission impossible! Ecco quel che succede: due o tre poeti si stimano, magari si amano tout-court, e su tale base organizzano un nucleo di reciproca legittimazione. Attratti dall’armonia, altri singoli si aggregano. Se il gruppo è gentile, continua ad ingolfarsi di nuovi ospiti ed affastellamenti inerti di materiale fino all’esplosione combinatoria ed al caos cognitivo. Se il gruppo invece fa selezione, cioè prova ad argomentare un filtro, si crea dei nemici davvero implacabili, che c’è da pregare Iddio si limitino al trolling e non vengano a cercarti a casa! Gruppi rivali che vengono a contesa rappresentano poi uno spettacolo unico, esotico, da fauna di Burgess! A questo punto sul caos interviene il potere (del denaro, degli apparati, delle consorterie) che dice: visto che non siete in grado di mettervi d’accordo su chi è il più bravo fra di voi, allora scelgo io! La scelta arbitraria risolve il problema cognitivo e lascia il popolo stupido e soddisfatto. Beh, Magda, quando chiedo una spiegazione mi aspetto che essa mi venga data in un linguaggio non poetico, o solo blandamente metaforico. Dire “parola pura è la poesia” e cc. è a sua volta poesia, può essere intesa a vari livelli, ma non “costringe” a nulla, se non per via di plagio o fascinazione. Ci sono, ci saranno per un bel po’, gli adoratori di Heidegger, a me basta che ci siano anche gli antidoti, volendoli (p.es: http://mondodomani.org/dialegesthai/gm01.htm). Il problema è che GiusCo forse pretende che l’estetica abbia un potere cognitivo (e quindi un dividendo sociale) analogo a quello della scienza. Ma questo è assurdo, dato che l’effetto dell’estetica dipende da un tirocinio dei corpi alquanto incontrollabile (ed anche da predisposizoni, nevero, direbbe Carotenuto :). Non c’è proprio base razionale per un’imposizione autoritaria, meglio sarebbe che si dichiarasse subito la propria appartenenza all’aristocrazia (perché me l’ha detto il mio amico, che è fighissimo ecc.) e morta lì. L’unico sbocco teoricamente possibile era forse quello costituito dall’archetipo junghiano: l’artista minatore scava solitario nel tunnel nella propria particolarità ed improvvisamente risbuca alla superficie, riportando dal suo viaggio agli inferi qualcosa che i meno coraggiosi rimasti in superficie riconoscono commossi come una loro “possibilità” prima sconosciuta, decretandone l’universalità. Ma si tratta di una favoletta un poco screditata, per quanto comoda per l’artista, talmente comoda che si può continuare a preferirla a dispetto delle più aspre mode che sono sopraggiunte. Grazie Giusco - e scusa l’impazienza, sono in un momento di fame epistemica e devo anche sbrigarmi perché il tempo stringe: ho annusato la tua risposta ed intravedo con piacere della “trippa per gatti”. Adesso mi prendo un po’ il tempo per rimettere in ordine le idee, ciao :-) Come amava fare l’inquisizione, apocrifo ci ha esposto ai suoi strumenti di tortura. Devo dire che sono abbastanza impressionanti, mi sento davvero indotto ad una confessione (ebbene sì, bleffavo, non capisco un kaiser di quello che sto sparando!) però penso che essi vadano selezionati e spietatamente calati nel punto appropriato del discorso. Elencati soltanto in generale, essi suggeriscono che apocrifo è certamente da temere (punirà prontamente le nostre ingenuità, evviva!) ma che forse non accetterà di scendere tra i meno sfaccettati (sob!). @Magda non saprei proprio, la domanda mi suona troppo astratta. Su Wittgenstein poi sono tentato di fidarmi di quel testone di Odifreddi ( http://www.vialattea.net/odifreddi/bio/witt.htm ) e quindi lasciar perdere la storia della filosofia, perché la filosofia corrente già da sola è abbastanza ingombrante (vedi quel frammento, che devo sottoscriverere, di Baricco). Caro GiusCo, una spiegazione piena di buon senso la tua. L’iconicità che descrivi mi appare come quella ricercata “concentrazione” del senso intorno ad un significante “ben formato” che coincide abbastanza con ciò che normalmente ci aspettiamo dall’oggetto artistico, e che sappiamo bene non si trovi per caso, ma richieda l’acquisizione della sapienza tramandata da una tradizione e la successiva “modulazione” all’interno di questi vincoli (la cui “forzatura” richiede una padronanza ancora più grande). Dove stava allora il nostro contendere? Forse ho capito: io mi ero già in qualche modo arreso all’esplosione combinatoria, e “bariccavo” su nuovi scenari, mentre tu e Conte sembrate suggerirmi che un occhio esperto ne può scartare senza sforzo mille al giorno, di falsi candidati. Ovvero, che non serve affatto, per rendere giustizia a questi tapini (ed indurli ad accettare serenamente l’esclusi one dall’arca) scendere a quei livelli quasi morbosi di conoscenza autobiografica e ambientale che si riserva ai “consacrati”. Insomma che la strutturazione delle competenze letterarie, la chiesa della letteratura, può ancora funzionare, è ancora in grado di produrre “canoni” convincenti, “oggettivi”, basterebbe qualche sostituzione illuminata nei gangli del sistema. Può anche darsi, devo sospendere il giudizio, tanto più che la poesia non è il mio campo. Mantengo soltanto qualche dubbio legato alle mie frequentazioni assolutamente neutrali: ogni “giro” sembra convinto di possedere quell’occhio esperto - da qui la necessità, un po’ disperata, del ricorso all’orecchio innato e al dono di natura - è un vero guaio quando sono i competenti, non i semi-letterati, a non riuscire a mettersi assolutamente d’accordo. Un altro forte elemento di dubbio è costituito dagli esiti dell’arte contemporanea, che osservo con attenzione ancora maggiore (eh beh, qui c’è anche qualche interesse un po’ meno disinteressato). Ma andrei a ripertermi, e già lo faccio troppo spesso. Per questo thread son pago! Un saluto a tutti e grazie.
...
La facile possibilità di scrivere lettere deve, da un punto di vista meramente teorico, aver portato nel mondo una terribile disgregazione di anime. Si tratta, infatti, di un rapporto con spettri, e non soltanto con il fantasma del destinatario ma anche con il proprio fantasma, che si manifesta tra le righe della lettera che si sta scrivendo e tanto più in una serie di lettere, dove una lettera corrobora l'altra e ha modo di riferirsi ad essa come a un testimone. [..] Si può pensare ad una persona lontana, e si può aver presa su una persona vicina: tutto il resto trascende l'umana capacità. Scrivere lettere significa, tuttavia, denudarsi di fronte agli spettri, cosa di cui questi sono in bramosa attesa.
F.KAFKA
Felice Beato
Crucifixion of the Male Servant Sokichi Who Killed the Son of His Boss
and Was Therefore Crucified. He Was 25 Years Old. 1865-68
Albumen print
From the anthology THE BODY Photoworks of the Human Form
William A.Ewing
Thames and Hudson - LONDON
Voglio andare dove
né il maledetto Citerone mi veda,
né i miei occhi possano vedere il Citerone,
né esista memoria alcuna del tirso:
queste cose se le tengano care le altre Baccanti.
Giunta a vedersi nello specchio di Dioniso la Grecia classica si autodistrugge. La rappresentazione delle Baccanti, effettuata dopo la morte di Euripide, coincide con gli ultimi anni della guerra del Peloponneso, vero suicidio mimetico di questa cultura. [G.Fornari - Fra Dioniso e Cristo]
Postato da: elio_c a 17:18 | link | commenti (2)